Nel cuore del Piemonte, dove la cucina parla il dialetto della terra, c’è un taglio di carne che racconta una storia antica:
quella del brutto e buono.
Un nome schietto, che non cerca di abbellire ciò che non è necessario.
Brutto a vedersi, buono da mangiare.
È così che lo conoscono generazioni di cuochi, macellai e famiglie.
Questo taglio, che corrisponde alla parte del collo del bovino adulto, non ha mai goduto dei riflettori.
Non è tenero al tatto né lucido come un filetto, ma ha sempre avuto un posto fisso nelle cucine di chi la carne la conosce davvero.
In Piemonte, il brutto e buono ha una sua dignità,
radicata nel buon senso contadino: niente si butta, tutto si valorizza.
La sua fama si è trasmessa nel tempo non per estetica, ma per risultati.
In un’epoca in cui il valore della materia prima si misura anche in sostenibilità e rispetto per l’animale, il brutto e buono torna attuale più che mai.
Non è solo un taglio economico: è un simbolo di una cultura che sa trarre il meglio da ciò che ha, senza sprechi.
Chi lavora la carne lo sa: non conta solo l’aspetto, ma come si comporta in cottura.
Il brutto e buono è ricco di tessuto connettivo e venature di grasso, elementi che lo rendono apparentemente impegnativo — ma in realtà lo rendono perfetto per le cotture lunghe e lente, quelle in grado di trasformare la sua struttura in qualcosa di straordinario.
Il segreto è tutto nella chimica naturale del taglio:
la concentrazione di collagene lo rende duro all’inizio, ma durante la cottura si scioglie lentamente, regalando morbidezza e sapore.
Anche il grasso intramuscolare gioca un ruolo fondamentale, contribuendo all’effetto “fondente” della carne e intensificando la componente umami, cioè quella sapidità rotonda che rende il piatto appagante.
Dal punto di vista organolettico, il brutto e buono ha un profilo aromatico profondo, che si sviluppa solo con il tempo. Serve pazienza, ma il risultato è una carne ricca, intensa e piena di carattere.












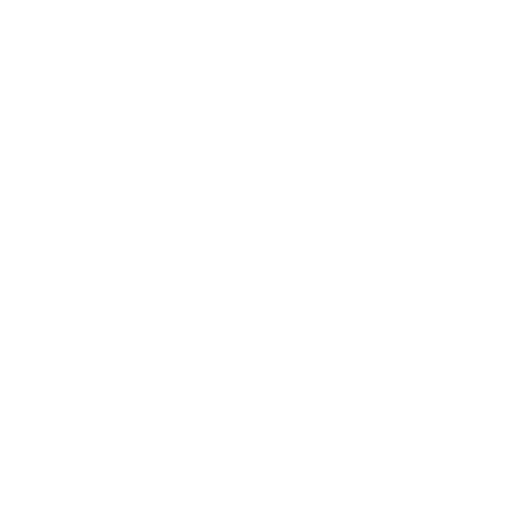
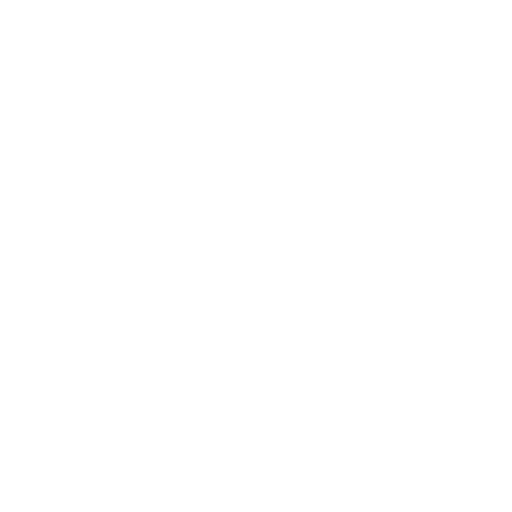








 0183.54009
0183.54009